Paola Ceccotti
LIBRO PER RAGAZZI
ILLUSTRAZIONI DI ALICE BARBIERI
Prologo
Correva l’anno 1765
Agostino si era trovato a passare dalla città di Liburnia accompagnando il proprio padrino, e zio, che doveva andare a trattare da un vecchio mercante giudeo certe mercanzie provenienti dall’oriente.
Liburnia a quei tempi era famosa per gli stabilimenti di lavorazione delle pietre dure, smalti e alabastri, per le fabbriche di corallo, per le relazioni commerciali che facevano arrivare da paesi lontani tessuti pregiati e preziosi gioielli per importanti famiglie.
Per Agostino era il primo viaggio che lo portava lontano da casa.
Prima parte
Agostino e i segreti di Liburnia
I
L’arrivo a Liburnia
Agostino e lo zio Giovanni erano partiti da giorni e giorni, un mese quasi, soffermandosi in alcuni borghi conosciuti dallo zio che vi aveva fatto buoni acquisiti.
Avevano attraversato strade e sentieri che talvolta si inoltravano nei boschi inerpicandosi in anguste salite e scendendo in ripidi pendii senza che si vedesse anima viva se non qualche solitario viandante o mercanti che come loro erano in cammino per affari. Viaggiavano a cavallo seguiti da un carro portato da due loro fidi dipendenti sul quale sarebbero state caricate le mercanzie e dove avevano sistemato alcuni bauli che contenevano oggetti necessari come indumenti, calze, mantelle, e guide con indicazioni di viaggio, e anche un’arma da fuoco corta per difesa personale se ce ne fosse stato bisogno, perché si sa che briganti e avventurieri di ogni tipo erano un pericolo che minacciava i viaggiatori. Percorrendo vie che già anticamente i pellegrini avevano attraversato nel loro viaggio verso i luoghi di culto cristiano, Agostino aveva visto per la prima volta nuovi paesi e gente diversa e il desiderio di conoscere lo aveva in parte ripagato della stanchezza e del disagio. Finalmente lo zio gli aveva detto che erano vicini a Liburnia, c’era soltanto da superare la zona malsana che circondava a nord la città. Vi erano paludi, fossi, acquitrini, e dovevano stare attenti che le ruote del carro non si impantanassero. Attraversarono ben sette ponti poi si trovarono nella macchia di Tombolello, lì lo zio lo avvertì di stare in guardia perché era un posto frequentato da bande di balordi che avevano abbandonato la vita civile e campavano di furti e aggressioni ai danni dei poveri uomini dabbene. Dopo Tombolello decisero che il carro con i guidatori si sarebbe fermato prima, presso una locanda dalle parti di Calambrone che apparteneva ad un parente dei due, dove avrebbero aspettato gli ordini per il carico.
Giovanni e Agostino presero un po’ delle loro cose e proseguirono da soli percorrendo la strada che dalla chiesa di S. Stefano si congiunge alla via delle Cateratte. Superarono un ponticello che la univa ai nuovi quartieri sugli isolotti che stavano cominciando a sorgere e arrivarono alla darsena. Liburnia, città di mare e di commercio, era davanti a loro, indaffarata e gremita di gente.
Alla loro vista grandi imbarcazioni si stagliavano imponenti sulle onde del mare che rilucevano attraversate dai raggi di sole. Agostino si lasciò sfuggire una espressione di meraviglia. Il cielo era sgombro di nubi, il sole stava percorrendo la curva discendente verso la linea dell’orizzonte dove avrebbe finito la sua corsa tuffandosi nel mare ancora mosso da cavalloni, strascico del vento di libeccio, ma ancora così forte da far sobbalzare le barche e i vascelli ancorati a riva. L’aria rinfrescata dalla brezza marina carezzava dolcemente la pelle, una sensazione del tutto nuova per Agostino.
“Guarda zio, non avevo mai visto uno spettacolo così, il mare, immenso, lontano laggiù – disse come estasiato indicando l’orizzonte - … chissà cosa ci sarà dall’altra parte, altri mondi e altre genti…” .
“In verità, non credo – rispose lo zio che non amava quella inclinazione del nipote a prendere il volo con la fantasia, riportandolo bruscamente a considerazioni più concrete – che l’uomo sia poi così tanto diverso a seconda del posto dove si trova a nascere, sicuramente laggiù, al di là del mare, ci saranno paesi dove ci sono uomini, donne, che nascono, lavorano, vivono e muoiono proprio come qui, anche se hanno abitudini diverse e parlano lingue a noi sconosciute, e come noi ci saranno mercanti che per lavorare devono sopportare le fatiche e fare sacrifici”. Camminarono ancora per le strade della città e arrivarono nella piazza Grande, che grande lo era per davvero, certo più di ogni altra vista prima, dal Palazzo della Comunità si apriva uno grande spazio attraversato da persone, calessi, cavalli , che arrivava fino alla cattedrale. Da lì partiva la strada principale che da una parte si congiungeva alla darsena, dall’altra si prolungava fino ai bastioni che separavano la città dalla campagna. Agostino era frastornato da tanta confusione di voci diverse, una specie di Babele, gente dalla pelle chi chiara e chi scura affaccendata e rumorosa che accendeva la piazza del colore degli abiti sgargianti e delle grida e schiamazzi di venditori e ragazzi chiassosi. C’erano bambini cenciosi che strillavano aggrappati alle lunghe gonne delle madri, trafficanti che attiravano la clientela mostrando la mercanzia, mendicanti seduti per terra che chiedevano con una litania lamentosa a chi passava qualche soldo. Si notavano anche personaggi esotici e stravaganti, per i ricchi abiti con cui erano abbigliati, abiti damascati dai colori accesi, verde brillante come le foglie bagnate dalla rugiada, rosso intenso come il sole al tramonto in certe magiche giornate, giallo luminoso come i cespugli delle ginestre. Si diffondeva nell’aria una mescolanza di odori, quello acre proveniente dalle bestie che nella piazza si trovavano in attesa delle trattative dei padroni (cavalli, asini, galline…), quello delle verdure in mostra nei vicini banchi al mercato, insieme all’intenso aroma di spezie e profumi che ricordavano l’Oriente al di là del mare, eppure così vicino.
Agostino, confuso da tutto quel movimento, si sentiva sbalordito e con lo sguardo cercava quello dello zio come ad avere una guida sicura, ma quasi inconsapevolmente la sua attenzione veniva catturata dalle donne, la cui esuberanza, particolarmente nelle più giovani, era al limite della sfrontatezza, ed esplodeva nelle forme sinuose e nei prosperosi seni che appena si intravedevano dalle vesti scollate. Sopra le gonne portavano ampi grembiuli dai vivaci colori legati da nastri, in testa la pezzola ed alcune, sopra a questa, un grande cappello. Al collo tante erano adornate con un vezzo di grani d’oro con un ciondolo in filigrana, o una crocetta, chi invece portava una collana di corallo. Avevano l’aria di muoversi come regine, e con i bambini aggrappati alle vesti e i panieri sulla testa con portamento altero attraversavano la piazza. Alcune erano indaffarate ad acquistare dagli ambulanti che stazionavano nella piazza il cibo necessario a sfamare quelle bocche rapaci, altre con brocche andavano alla fontana a prendere acqua, altre erano a gruppi di due o tre e conversavano amabilmente scambiandosi i saluti. Insieme a questo frastuono intorno fervevano i preparativi per la festa in onore di sua Maestà Serenissima Granduca di Toscana, e i manovali si muovevano nella piazza a montare impalcature, strutture dove si sarebbero svolti i tornei, le gare in onore del Granduca. I vascelli di Guerra del Granduca avevano inalberato per la prima volta a Liburnia la nuova bandiera del Paviglione Toscano formato da tre strisce, la prima e l’ultima rossa, quella di mezzo bianca con in mezzo raffigurato lo stemma d’armi del Granducato. Oltre la via Maestra, la via principale, nello specchio d’acqua antistante, si innalzava maestosa la Fortezza Vecchia su cui per la prima volta era stato issato il Paviglione.
Agostino e lo zio, stanchi, sporchi e sudati per il lungo viaggio, chiedevano informazioni a chi passava sulle locande aperte nelle vicinanze, per trovare un alloggio per la notte, ma sembrava che tutte fossero al completo. Rasentando il fosso Santa Trinita erano infine arrivati all’Osteria dei Tre Mori situata nel vicolo che dalla Crocetta mette in via Sant’Anna, avventurandosi in una zona remota e solinga del peggior quartiere della città dove una persona perbene non può mettere piede al sopraggiungere della notte senza il rischio di essere assalito da delinquenti, con pericolo di essere sventrato. E dove anche di giorno c’era grande probabilità, quasi una certezza, di essere derubato di orologio, borsa, o qualsiasi altra cosa. L’Osteria dei tre Mori aveva una piccola insegna e una particolarità, la porta invece di essere verticale era orizzontale alla via e consisteva in una apertura quadrata della larghezza di due braccia con un coperchio che alzandosi come una grande scatola lasciava intravedere i sottostanti scalini di una scala tortuosa e scura che conduceva alla prima sala della locanda, in realtà quasi una cantina. Agostino e lo zio, spinti dalla curiosità, decisero di seguire le persone che vedevano entrare. Si ritrovarono in una stanza senza palco, nera e umida, con il soffitto a volta. Quelli che li avevano preceduti erano già spariti, non si capiva dove. Entrarono nella seconda sala. Questa, da cui si dipartivano altre due uscite, era arredata, per così dire, con tavolacci e panche, ma anche qui non c’era nessuno, passarono in una della stanze comunicanti, completamente deserta, dove erano sistemati dei pagliericci. Vi si vedevano tre bodole che mettevano in anditi sotterranei destinati a ricevere il frutto della “busca”, nome con cui veniva chiamato a Liburnia il furto giornaliero praticato da certi bricconi a danno dei poveri sfortunati forestieri. Naturalmente zio e nipote non erano a conoscenza di queste abitudini altrimenti avrebbero velocemente cercato l’uscita. “C’è nessuno?” gridò Giovanni senza avere risposta. Si diressero verso l’ultima stanza, da cui provenivano delle voci. Si fermarono un attimo sulla soglia, sorpresi nel vedere che finalmente avevano scoperto presenze umane, che stavano indaffarate alla preparazione delle consumazioni. Questa sala era adibita a cucina, in un gran pentolone sul fuoco di un grande camino bolliva un brodo di dentice insieme a peperoni rossi e cannella e accanto in padella friggevano i totani, mentre la cuoca ne stava asciugando con il lino e infarinando altri.
La cuoca era una giovane donna di circa vent’anni, assai prosperosa, con i capelli neri raccolti in una treccia che le scendeva lungo la schiena, in cui stava infilato uno spillo con manico di rame dorato, il collo e le braccia nudi erano ornati da collane e braccialetti di grosso corallo rosso. Ella aveva un corsetto ricamato ad arabeschi e le spalle coperte con una pezzuola di seta allora detta delle Indie, di color rosa con fiori minuti. La gonnella era alla caviglia e faceva notare le scarpette scure, sopra a tutto teneva un grembiule di seta verde.
La giovane di nome Concetta, come la stava chiamando l’aiutante, appena li vide ebbe un trasalimento per l’inaspettata presenza, così affaccendata dietro alla cucina. Giovanni chiese se c’era da dormire ma la ragazza riprendendosi dal soprassalto rispose che era tutto occupato, potevano però ristorarsi mangiando un po’ di quello che stava cucinando. Si sedettero ad uno dei quattro tavoli disposti a due a due nella attigua sala da pranzo dietro la cucina. Potevano finalmente riprendersi dalle fatiche del viaggio e dalla fame che li attanagliava alla bocca dello stomaco. Intanto l’ambiente si era popolato di alcuni tipi che avevano l’aria di essere uomini di mare dai calzoni corti e colorati, e la pelle bruciata dal sole e dal vento, in particolare uno pareva quasi di casa, si era avvicinato a Concetta con una certa familiarità. Era basso di statura ma di struttura atletica, coi capelli neri e ricci, quasi arruffati, il colorito vivace, rendeva l’idea di una persona esuberante. Concetta cercava di allontanarlo così per celia, dicendo che aveva da fare e non era perdigiorno come lui, che continuava invece, divertendosi, a stuzzicarla. Il pranzo riuscì a saziarli essendo abbondante e gustoso.

Al tavolo insieme a loro si era seduto un vecchio, silenzioso e mal vestito, mangiava con il capo chino sul piatto. Ne approfittarono per chiedere se conosceva locande nelle vicinanze che avrebbero potuto ospitarli, accorgendosi però quasi subito anche dagli ammiccamenti dei presenti che era solo un povero ubriacone, uno dei tanti straccioni di cui erano popolate le strade, che vivevano di elemosina e carità, come quella che faceva Concetta ogni giorno offrendogli un pasto caldo. Uscendo, un uomo che aveva sentito la loro richiesta, si avvicinò con modi garbati. “Buona gente, se cercate un alloggio so io dove portarvi, qui vicino c’è la locanda di mio cugino, un posto sicuro, dove si mangia bene, si dorme senza timore di avere sorprese e si spende il giusto”, disse ridendo. Era un uomo di circa quarant’anni, di pelo fulvo, con capelli, barba e baffi, che formavano come un unico groviglio da cui spuntavano due occhi azzurri piccoli e vivaci. Giovanni aveva trovato la proposta assai gradita e decise di accogliere l’offerta presentandosi a quell’uomo che gli ispirava una istintiva fiducia. “Mi chiamo Giovanni e questo è mio nipote, siamo qui per commercio ma non pensavamo davvero di trovare tutto questo frastuono, tutte le locande sono al completo, se ne conoscete una libera vi seguiremo, basta che sia frequentata da gente onesta e tranquilla”.
“Dove vi porto è un posto familiare, dove non troverete filibustieri, non temete, garantisco io, mi presento sono Marco Tirabaldi consigliere anziano di questa città e tutta questa confusione in giro si deve ai preparativi per la festa in onore del Granduca, non vi spaventate Liburnia e in tempi normali un po’ meno caotica ”. Si diressero quindi verso quell’osteria che non era molto distante, si trovava in via della Voltina, tra la via Carraia e via della Venezia. Si chiamava “Croce di Malta” ed era esercitata da Monsù Beppe, vecchio marinaio a riposo, che la gestiva insieme alla figlia, Maria giovane donna che aveva cura del buon andamento della attività. “La locanda è rinomata perché ci sono stanze per dormire pulite e con confortevoli giacigli, e la sera si possono gustare saporite zuppe di pesce, conosciute nei dintorni come una vera specialità e inoltre il prezzo non è eccessivo, per un mese intero si chiede appena 1 ducato”. Entrarono nella taverna, che ad un primo impatto apparve buia e fumosa, con gli occhi sgranati per abituarsi all’oscurità tanto le stanze erano tenute nella penombra, subito contrattarono il prezzo per il pernottamento felici di aver finalmente trovato un alloggio, quindi dopo aver salutato e ringraziato la loro guida, salirono per una stretta e sconnessa scala al piano superiore dove, attraverso un ballatoio, si arrivava ad alcuni locali posti in fila uno all’altro. Entrarono nella stanzetta accompagnati dal ragazzo che lavorava per l’oste che si pose al loro servizio nel caso avessero bisogno di qualcosa, Giovanni gli dette una piccola mancia e lo congedò. La stanza era piccola con una finestrina dirimpetto alla porta di ingresso che si affacciava sul retrostante canale, dove c’erano ai lati due pagliericci, grossi sacchi gonfi di paglia e foglie secche, sui quali si sdraiarono immediatamente dopo aver gettato le loro bisacce per terra, scivolandovi sopra, nel fruscio dell’imbottitura.
I due si addormentarono come sassi, tanta era la stanchezza, svegliandosi dopo circa un’ora per il gran baccano che proveniva da fuori.
...








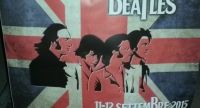
 roposto brani musicali lungo il percorso dei vicoli dello splendido borgo medievale, che sorge con il vicino Castello Della Gherardesca tra le armoniose colline coltivate a viti e olivi.
roposto brani musicali lungo il percorso dei vicoli dello splendido borgo medievale, che sorge con il vicino Castello Della Gherardesca tra le armoniose colline coltivate a viti e olivi.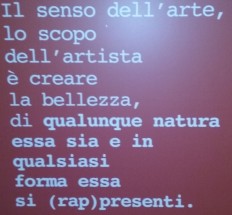
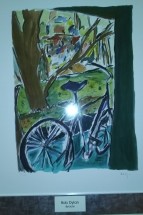
 inamiche interne si concretizzano con gratificazione di chi fruisce del prodotto creativo e dell'artista medesimo che riesce nel suo intento di conferire un contenuto concreto alle proprie fantasie, ai propri stati d'animo, i quali proiettati in una dimensione collettiva condivisa diventano attributi generali della umanità.
inamiche interne si concretizzano con gratificazione di chi fruisce del prodotto creativo e dell'artista medesimo che riesce nel suo intento di conferire un contenuto concreto alle proprie fantasie, ai propri stati d'animo, i quali proiettati in una dimensione collettiva condivisa diventano attributi generali della umanità.






